la cruna del lago: inizia cosi
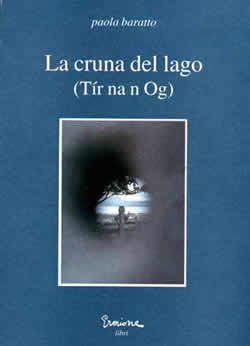 Attraversavo l’isola per la prima volta, con uno spirito che mi avrebbe procurato più rimpianti che ricordi.
Attraversavo l’isola per la prima volta, con uno spirito che mi avrebbe procurato più rimpianti che ricordi.
Concentrato sulla guida, vedevo il nuovo senza osservarlo e rinviavo il tempo delle emozioni, come se il momento dell’arrivo potesse riservarmi una gioia più piena.
Questo era prima, quando ancora non avevo appreso quell’arte da randagi che fa del viaggiare il vero fine del viaggio.
Durante l’ultimo centinaio di miglia avevo sbagliato strada in continuazione e l’orologio sul cruscotto ribadiva che stavo gettando via minuti, ore, una manciata di sabbia dietro le spalle. Non che ve ne fosse motivo, ma quell’idea mi innervosiva ed io vi attribuivo l’impreciso disagio che mi portavo dentro come un passeggero clandestino, mentre avanzavo verso il cuore muscoso di quel paese d’erba e di pietra.
Infissi nel mezzo di un bivio, come sfingi, paletti carichi di cartelli segnaletici mi costringevano di frequente a fermarmi per decifrare i loro testi oscuri: Cill Airne, Gleann Beithe, Cathair Saidhbhín…
Avevo varcato il confine, ero nei territori del Gaeltacht, dove incontrare un’insegna bilingue, per lo straniero che avesse abbandonato la strada principale, era una fortuna oltre che una rarità.
Evidentemente quello non era il mio giorno fortunato e sempre più spesso lasciavo che fossero i campi magnetici dell’immaginazione a governare l’ago della bussola, mentre la cartina spiegata sul sedile accanto era diventata un inutile supporto.
Tuttavia, intuii subito che dovevo essere arrivato quando, all’ennesima biforcazione, lessi “An Daingean”. Non soltanto perché indicata in direzione opposta a Cill Airne, che avevo già passato e che, essendo facilmente riconducibile al corrispettivo inglese “Killarney”, avevo adottato come punto di riferimento. Ma soprattutto perché c’era qualcosa lì intorno, un’impronta, un richiamo immediatamente percepibile, che in un istante, dai fondali limacciosi della memoria, fece affiorare i frammenti di certe descrizioni di Agostino.
“Ogni volta che ritorno – mi aveva detto – arrivo col fiato sospeso, con la paura che non sia più la stessa”.
Calcolando che mi sarebbero rimaste solo poche miglia di strada, accostai e mi concessi qualche minuto di respiro fuori dall’auto.
Il popolo gitano delle nuvole, in diaspora perenne dai deserti oceanici, mi correva incontro senza posa. E passando oltre, dentro l’arena grigia sopra la mia testa, metteva in scena il suo circo di strane creature mutanti: una testa di lupo era ingoiata da fauci di caimano, poi un nembo, gonfio come un cetaceo, arrivava a travolgerla, slabbrandola. Anime di schiuma! Il vento le rendeva libere, schiave; apriva i recinti, le disperdeva o le mandava a stallare sulla Baia di Dublino, che quella mattina avevo lasciato sotto un cielo cagliato e basso, leccato dai tetti.
Sempre, quando ripenso a quella giornata, quel momento è sicuramente il primo che, dal fascio intricato delle ore precedenti, riesco a spiccare ancora intriso dell’odoroso spessore emotivo di una sensazione.
Credo si trattasse di quell’intensa percezione del presente, che nella vita ti coglie all’improvviso e mai troppo spesso; con quel suo estremo di significanza che eccede la capienza del pensiero e tracimando si spreca – raramente qualche sua goccia ti allaga il cuore -.
Ciò che era stato e quello che doveva ancora venire… Erano in quell’arco infinitesimale, sintesi suprema del vissuto e insieme alchimia di visioni e di presagi, che dell’attimo presente sono la fantasia, l’intrigante sciamano.
Ero al limitare della contea più occidentale dell’isola; davanti a me, i promontori della penisola di An Daingean scivolavano più o meno dolcemente verso l’Atlantico, tuffandovi distese di un verde radioso, che esaltava l’ordito delle recinzioni a secco.
A chi l’osservava dall’alto, lasciava subito intuire un candore selvatico da anacoreta, con i pochi villaggi nascosti nelle pieghe delle sue insenature, ritorta e sbrecciata; un amo gettato nell’oceano e lì dimenticato.